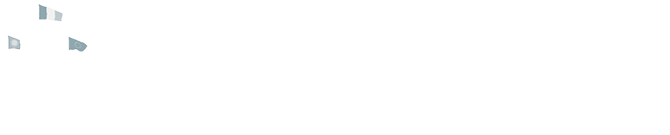Testi di Primo Levi e Pier Paolo Pasolini letti da Gigi Proietti
Ecco i testi di Primo Levi e di Pier Paolo Pasolini letti da Gigi Proietti
Da La chiave a stella, di Primo LeviQuesta breve lettura è tratta dal testo "Batter la lastra" contenuta ne La chiave a stella di Primo Levi.È la storia di un figlio che non capisce perchè il padre, nel frattempo scomparso, amasse tanto il suo mestiere finché egli stesso non comincia ad amare il proprio: la capacità di farlo con perizia.Le dicevo allora che bisogna tenere lo stagno pronto, che sia fuso ma non troppo caldo se no gli viene sopra una crosta rossa e si spreca del materiale; e sa, adesso è facile, ma a quel tempo i termometri erano roba da gran signori, e si giudicava della caloria così a stima, con lo sputo. Scusi, ma le cose bisogna chiamarle col loro nome: uno guardava se la saliva friggeva piano o forte o saltava addirittura indietro. A questo punto si prendono le cucce, che sono come delle filacce di canapa e non so neppure se hanno un nome in italiano, e si tira lo stagno sul rame come uno spalmerebbe il burro dentro una terrina, non so se ho reso l'idea; e appena finito si mette nell'acqua fredda, se no lo stagno invece che bello brillante resta come appannato. Vede, era un mestiere come tutti i mestieri, fatto di malizie grosse e piccole, inventate da chissà quale operaio nei tempi dei tempi, che a dirle tutte ci andrebbe un libro, e è un libro che non lo scriverà mai nessuno e in fondo è un peccato; anzi adesso sono passati gli anni mi rincresce di quella questione che ho fatto con mio padre, di avergli risposto e di averlo fatto stare zitto: perchè lui capiva che quel mestiere, fatto sempre in quella maniera e vecchio come il mondo, finiva che moriva con lui, e come io gli ho risposto che dell'acido cotto non me ne faceva niente, lui è rimasto zitto, ma si è sentito morire un poco già a quell'ora. Perchè vede, il suo lavoro, gli piaceva, e adesso lo capisco, perchè adesso a me mi piace il mio.Se si escludono istanti prodigiosi e singoli che il destino ci può donare, l'amare il proprio lavoro (che purtroppo è privilegio di pochi) costituisce la migliore approssimazione concreta alla felicità sulla terra: ma questa è una verità che non molti conoscono.
Ecco alcuni brani di un racconto che Pier Paolo Pasolini ha scritto nel 1950, dopo la morte in miniera di trentanove lavoratori a Charleroi, in Belgio. Il racconto, di dolorosa attualità, si intitola Sopra di noi, due chilometri di terra. Il protagonista è un ragazzo friulano emigrato che torna a casa per qualche giorno.Sei anni dopo, l'8 agosto del 1956, nella sciagurata miniera di Marcinelle muoiono 262 uomini, di cui 136 sono italiani. Eroi del lavoro di undici nazioni europee. L'Europa di oggi nasce anche su quella storica memoria."Le gallerie", diceva Davide all'Enal di San Giovanni, "si stendono parallele una sopra l'altra, a circa cento duecento metri di distanza, e sono messe in comunicazione fra loro da tanti budelli scavati nella roccia e alti non più di un quaranta centimetri. Ci si passa solo strisciando.Noi si discendeva in una squadra a mille o duemila metri di profondità, e dalla galleria ci infilavamo strisciando su per i budelli con la lampada e tutto il materiale occorrente così che stando distesi ci si poteva muovere appena. Traforavamo la roccia che sgretolandosi scorreva giù per il cunicolo lungo una specie di cunetta. Sulla testa, in alto, c'erano le scarpe del compagno, che si arrampicava ventre a terra puntando contro la roccia, verso la galleria superiore. Sopra di noi, due chilometri di terra."Il friulano di Davide, risuonante di accenti francesi o fiamminghi, era massiccio come quei due chilometri di terra? Allora Davide doveva avere un quattordici anni, certo non più di sedici. Ma io lo ricordavo ancora più giovane.Mi veniva in mente, tra le sue parole, la faccia che aveva nel '43: una faccia scura e bionda, celliniana come il suo nome. Era domenica, di notte, verso le due? vidi un'ombra esile e ferma. Era Davide ubriaco, coi suoi quattordici anni dipinti come se fossero d'oro sul viso e sui calzoni lunghi e leggeri.Lo salutai, egli venne avanti lungo il ciglio dello stagno e mi diede la mano, sorridendo. Era troppo ubriaco per parlare.Anche ora, all'Enal, è piuttosto ubriaco: ma il vino, il vecchio refosco friulano, o il bacò delle vigne materne, o il clinto del mezzogiorno domenicale, trova nel linguaggio di Davide reazioni diverse. Ci sono di mezzo i vent'anni e la birra fiamminga.Il viso è rimasto giovanissimo, imberbe: gli occhi trasparenti, d'un azzurro così chiaro che non si distingue la cornea dalla pupilla. Eppure com'è invecchiato. C'è presso la bocca una ruga - la ruga dei duemila metri di terra, dei caffè di Charleroi, delle meretrici nordiche. Una ruga stampata in Davide come un'ombra, un'infiammazione, una piaga. Parla con confidenza e larghezza, già serio come un vecchio emigrante, rotto, bruciato. Dentro di lui l'estero giganteggia, dalle Alpi al Mare del Nord.Il Belgio si è sovrapposto al piccolo Friuli succhiandone la vita.Ora questa licenza, questo breve ritorno al paese non è che una concessione: quello che conta è ormai ciò che è al di là delle Alpi, la miniera.Fra pochi giorni sarebbe ripartito.Alla stazione di Casarsa, seppure non con la solennità della prima volta, i suoi compagni lo scorteranno tra risa e manate sulle spalle.E Davide valicherà di nuovo le Alpi.1950: il destino di Davide è incallito. Se mai lo rivedrò sarà fra molti anni, quando saremo senza gioventù da consumare, con una vecchiaia da rimpatriati?. se mai lo rivedrò? perché dei trentanove morti di Charleroi, tre sono italiani.Ricordo il giorno in cui sono partiti. La stazione di Casarsa era piena di gioventù. Quelli di San Giovanni erano i più allegri: splendidi come pioppi avevano attorcigliato intorno ai colli i fazzoletti rossi e viola e reggevano i bagagli come aratri. ? Bruno Cesarin e Davide, vicini di casa e ora probabilmente vicini di posto nel treno, rivolti torvamente alle immense distanze che li aspettavano, la Lombardia, la Svizzera? Se ne stavano tutti in gruppo, una trentina, davanti alla stazione bombardata, con intorno un nugolo di amici, e più in disparte, le donne ammutolite.
leggi tutto
Da La chiave a stella, di Primo LeviQuesta breve lettura è tratta dal testo "Batter la lastra" contenuta ne La chiave a stella di Primo Levi.È la storia di un figlio che non capisce perchè il padre, nel frattempo scomparso, amasse tanto il suo mestiere finché egli stesso non comincia ad amare il proprio: la capacità di farlo con perizia.Le dicevo allora che bisogna tenere lo stagno pronto, che sia fuso ma non troppo caldo se no gli viene sopra una crosta rossa e si spreca del materiale; e sa, adesso è facile, ma a quel tempo i termometri erano roba da gran signori, e si giudicava della caloria così a stima, con lo sputo. Scusi, ma le cose bisogna chiamarle col loro nome: uno guardava se la saliva friggeva piano o forte o saltava addirittura indietro. A questo punto si prendono le cucce, che sono come delle filacce di canapa e non so neppure se hanno un nome in italiano, e si tira lo stagno sul rame come uno spalmerebbe il burro dentro una terrina, non so se ho reso l'idea; e appena finito si mette nell'acqua fredda, se no lo stagno invece che bello brillante resta come appannato. Vede, era un mestiere come tutti i mestieri, fatto di malizie grosse e piccole, inventate da chissà quale operaio nei tempi dei tempi, che a dirle tutte ci andrebbe un libro, e è un libro che non lo scriverà mai nessuno e in fondo è un peccato; anzi adesso sono passati gli anni mi rincresce di quella questione che ho fatto con mio padre, di avergli risposto e di averlo fatto stare zitto: perchè lui capiva che quel mestiere, fatto sempre in quella maniera e vecchio come il mondo, finiva che moriva con lui, e come io gli ho risposto che dell'acido cotto non me ne faceva niente, lui è rimasto zitto, ma si è sentito morire un poco già a quell'ora. Perchè vede, il suo lavoro, gli piaceva, e adesso lo capisco, perchè adesso a me mi piace il mio.Se si escludono istanti prodigiosi e singoli che il destino ci può donare, l'amare il proprio lavoro (che purtroppo è privilegio di pochi) costituisce la migliore approssimazione concreta alla felicità sulla terra: ma questa è una verità che non molti conoscono.
Ecco alcuni brani di un racconto che Pier Paolo Pasolini ha scritto nel 1950, dopo la morte in miniera di trentanove lavoratori a Charleroi, in Belgio. Il racconto, di dolorosa attualità, si intitola Sopra di noi, due chilometri di terra. Il protagonista è un ragazzo friulano emigrato che torna a casa per qualche giorno.Sei anni dopo, l'8 agosto del 1956, nella sciagurata miniera di Marcinelle muoiono 262 uomini, di cui 136 sono italiani. Eroi del lavoro di undici nazioni europee. L'Europa di oggi nasce anche su quella storica memoria."Le gallerie", diceva Davide all'Enal di San Giovanni, "si stendono parallele una sopra l'altra, a circa cento duecento metri di distanza, e sono messe in comunicazione fra loro da tanti budelli scavati nella roccia e alti non più di un quaranta centimetri. Ci si passa solo strisciando.Noi si discendeva in una squadra a mille o duemila metri di profondità, e dalla galleria ci infilavamo strisciando su per i budelli con la lampada e tutto il materiale occorrente così che stando distesi ci si poteva muovere appena. Traforavamo la roccia che sgretolandosi scorreva giù per il cunicolo lungo una specie di cunetta. Sulla testa, in alto, c'erano le scarpe del compagno, che si arrampicava ventre a terra puntando contro la roccia, verso la galleria superiore. Sopra di noi, due chilometri di terra."Il friulano di Davide, risuonante di accenti francesi o fiamminghi, era massiccio come quei due chilometri di terra? Allora Davide doveva avere un quattordici anni, certo non più di sedici. Ma io lo ricordavo ancora più giovane.Mi veniva in mente, tra le sue parole, la faccia che aveva nel '43: una faccia scura e bionda, celliniana come il suo nome. Era domenica, di notte, verso le due? vidi un'ombra esile e ferma. Era Davide ubriaco, coi suoi quattordici anni dipinti come se fossero d'oro sul viso e sui calzoni lunghi e leggeri.Lo salutai, egli venne avanti lungo il ciglio dello stagno e mi diede la mano, sorridendo. Era troppo ubriaco per parlare.Anche ora, all'Enal, è piuttosto ubriaco: ma il vino, il vecchio refosco friulano, o il bacò delle vigne materne, o il clinto del mezzogiorno domenicale, trova nel linguaggio di Davide reazioni diverse. Ci sono di mezzo i vent'anni e la birra fiamminga.Il viso è rimasto giovanissimo, imberbe: gli occhi trasparenti, d'un azzurro così chiaro che non si distingue la cornea dalla pupilla. Eppure com'è invecchiato. C'è presso la bocca una ruga - la ruga dei duemila metri di terra, dei caffè di Charleroi, delle meretrici nordiche. Una ruga stampata in Davide come un'ombra, un'infiammazione, una piaga. Parla con confidenza e larghezza, già serio come un vecchio emigrante, rotto, bruciato. Dentro di lui l'estero giganteggia, dalle Alpi al Mare del Nord.Il Belgio si è sovrapposto al piccolo Friuli succhiandone la vita.Ora questa licenza, questo breve ritorno al paese non è che una concessione: quello che conta è ormai ciò che è al di là delle Alpi, la miniera.Fra pochi giorni sarebbe ripartito.Alla stazione di Casarsa, seppure non con la solennità della prima volta, i suoi compagni lo scorteranno tra risa e manate sulle spalle.E Davide valicherà di nuovo le Alpi.1950: il destino di Davide è incallito. Se mai lo rivedrò sarà fra molti anni, quando saremo senza gioventù da consumare, con una vecchiaia da rimpatriati?. se mai lo rivedrò? perché dei trentanove morti di Charleroi, tre sono italiani.Ricordo il giorno in cui sono partiti. La stazione di Casarsa era piena di gioventù. Quelli di San Giovanni erano i più allegri: splendidi come pioppi avevano attorcigliato intorno ai colli i fazzoletti rossi e viola e reggevano i bagagli come aratri. ? Bruno Cesarin e Davide, vicini di casa e ora probabilmente vicini di posto nel treno, rivolti torvamente alle immense distanze che li aspettavano, la Lombardia, la Svizzera? Se ne stavano tutti in gruppo, una trentina, davanti alla stazione bombardata, con intorno un nugolo di amici, e più in disparte, le donne ammutolite.